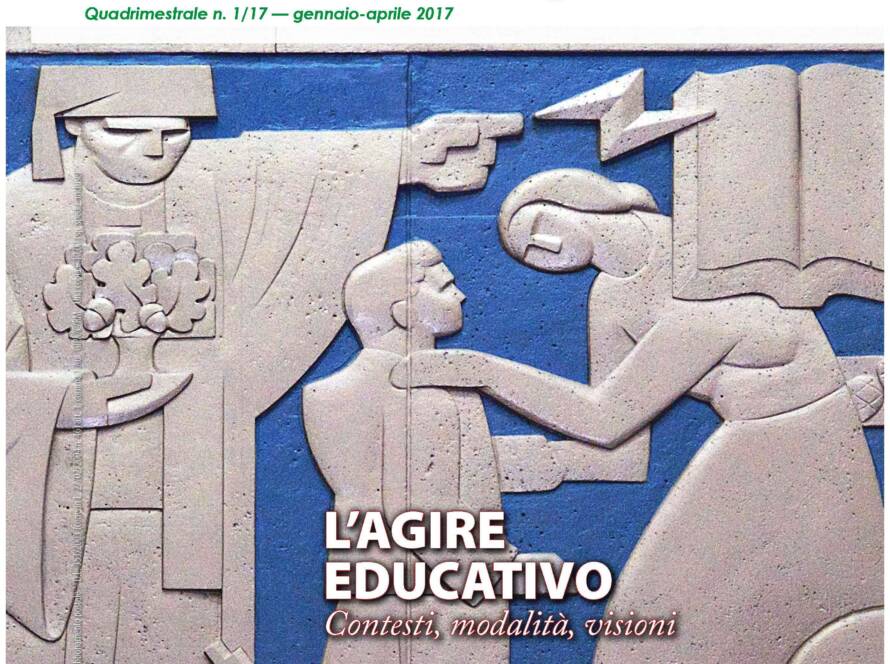È di poco tempo addietro la notizia che i cittadini italiani non saranno chiamati a pronunciarsi sul regionalismo c.d. “differenziato” in quanto il referendum sulla legge n. 86 del 2024, contenente “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione”, è stato dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale.
Ripercorriamo, seppure sinteticamente e semplificando al massimo, quanto è accaduto.
Facciamo un passo indietro
Alleggerita la morsa della pandemia, come si sa, si è tornato a discorrere di regionalismo “differenziato” e si è giunti all’emanazione della l. n. 86 del 26 giugno 2024; tale normativa è stata oggetto di richiesta di referendum abrogativo ma è stata impugnata dinanzi alla Corte costituzionale da quattro Regioni (Puglia, Toscana, Sardegna e Campania).
Dalla sent. n. 192 del 2024 la normativa in discorso è uscita “a pezzi”; in estrema sintesi, con tale decisione, alcune previsioni della l. n. 86 sono state dichiarate incostituzionali, altre sono state reinterpretate e altre sono state fatte salve.
D’altra parte, che le criticità fossero molte era stato fatto notare da un “coro” di voci che si erano fatte sentire all’interno della società; tra queste, vanno annoverate quelle della dottrina costituzionalistica ma anche della Chiesa e di molti altri (anche su questo sito: sia consentito rinviare al mio articolo dal titolo: “Regionalismo differenziato. Così non va”).
Due precisazioni si rendono opportune, alla luce della sent. n. 192 del 2024.
Per prima cosa, la Consulta ha escluso che l’intera legge contrastasse con la Costituzione. Secondariamente, l’art. 116, III comma, Cost., sulla base del quale le Regioni a statuto ordinario possono richiedere la c.d. “autonomia differenziata” in una serie di materie non provoca una contraddizione interna al dettato costituzionale. In poche parole, il c.d. regionalismo “differenziato” – almeno, in astratto – può realizzarsi, ma non nel modo (in gran parte) voluto dalla legge n. 86 del 2024.
Si badi, peraltro, che non è necessaria una legge per realizzare il regionalismo “differenziato”, in quanto l’art. 116, III comma, Cost. poteva (e può) essere inverato nell’esperienza a prescindere da un intervento dal legislatore, che però aveva (ed ha) – ovviamente – la facoltà di legiferare in materia al fine di specificare maggiormente quanto disciplinato in Costituzione.
Gli ulteriori passaggi
La legge prescrive che l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione, prima, e la Corte costituzionale, dopo, si pronuncino sulla proposta di referendum per verificare se quest’ultimo si possa tenere. Si tratta di due tipi di controllo molto diversi, ma il punto non può essere approfondito in questa sede.
Passato indenne il primo vaglio, la proposta di referendum si è arenata dinanzi alla Consulta, che invece – con la sent. n. 10 del 2025 – ha dichiarato inammissibile il referendum per mancanza di chiarezza nel quesito, uno dei requisiti richiesti dalla stessa giurisprudenza costituzionale.
In poche parole, i cittadini avrebbero potuto incontrare non poche difficoltà a comprendere su che cosa si sarebbero dovuti esprimere ossia quali fossero le parti che sarebbero rimaste da abrogare o da lasciare in vita della legge n. 86 del 2024, oggetto del significativo “restyling” operato dalla stessa Corte costituzionale.
E adesso che accade?
Messo da canto il referendum, occorre intanto chiedersi se ciò che resta della legge n. 86 è applicabile. Venute meno alcune norme di particolare rilievo, le restanti risultano squilibrate e, dunque, bisognose di un ulteriore intervento del legislatore che possa rimediare alle lacune causate dalla pronunzia della Consulta. D’altro canto, occorre che lo Stato definisca previamente con legge i “livelli essenziali delle prestazioni” concernenti i diritti civili e sociali bisognosi di uniforme tutela per l’intero territorio della Repubblica. Si deve infatti scongiurare la possibilità di dare vita ad un Paese che vada “a due velocità” ossia che aumenti il divario tra Regioni ricche e Regioni povere nella tutela dei diritti fondamentali, vera ratio dell’autonomia.
Ovviamente, però, il legislatore statale non può fare “rivivere” norme della l. n. 86 dichiarate incostituzionali.
In ogni caso, poiché – come detto – la previsione costituzionale da ultimo richiamata non richiede di essere attuata necessariamente tramite una legge, in qualunque momento una Regione a statuto ordinario potrebbe avviare la procedura descritta nell’art. 116, III comma, Cost. e chiedere, appunto, “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, di cui potrà giovarsi – come detto – dopo che saranno stati fissati i “livelli essenziali” suddetti.
In conclusione
L’art. 116, III comma, Cost. si pone in diretta attuazione dell’art. 5 Cost.; infatti, il regionalismo “differenziato” non appare, a priori, in antinomia con il modello di regionalismo voluto dai Costituenti, su ispirazione di don Sturzo, vero “padre” delle Regioni nonché “alfiere del regionalismo politico” (Antonetti). È necessario, però, com’è ovvio, che esso si realizzi in modo compatibile con lo “spirito” della Costituzione. Perché ciò accada la componente “cooperativa” deve rimanere prevalente rispetto a quella “competitiva”.
In conclusione, il regionalismo differenziato, per essere costituzionalmente ammissibile, non potrà che preservare l’intera tavola dei valori costituzionali e, in primis, quelli di solidarietà, di eguaglianza, di unità e di indivisibilità della Repubblica.